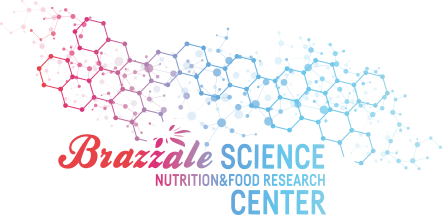Brazzale S.p.a. è presente a “TuttoFood” con il suo stand sui lattiero-caseari, ma arricchisce la sua partecipazione organizzando un convegno sul tema “I dazi e gli altri vizi” nell’ambito della stessa manifestazione. In programma gli interventi del politologo Alberto Mingardi, presente attraverso un video preregistrato, di Camillo Langone esperto d’arte e giornalista, di Luigi Mariani esperto di problematiche ambientali e docente associato nell’Università di Brescia e dell’Avv. Roberto Brazzale, titolare di Brazzale S.p.A.
In programma anche la presentazione di una nota-testo di Fernando Tateo, Ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari e Direttore Scientifico del Centro Analitico BSC, presentato in riassunto in sede di convegno e riportato in forma integrale al termine di questa nota (*).
Alla società Brazzale S.p.A. nell’ambito TuttoFood è stato attribuito il 1° posto del Premio “Innovazione di prodotto” del “Better Future Award 2025” by Mark Up e GDOweek per il settore Latte, Formaggi e Latticini. L’oggetto del Premio è il seguente: Burro delle Alpi a basso contenuto di Sodio con Levosod-Pro.

Da dx vs sx: Roberto Brazzale, Monica Bononi, Fernando Tateo, Camillo Langone.
Alla stessa Società Brazzale S.p.A. è stato riconosciuto il Premio “Migliore innovazione di prodotto senza lattosio 2024” by “Formaggi&Consumi” e “Alimentando.info”.
L’oggetto del premio è il seguente: Burro delle Alpi Pro senza Lattosio.
La foto fa riferimento alla presentazione tenutasi in sede “TuttoFood” del testo “La Nuova Era di Latte e Derivati” con Editors Fernando Tateo e Monica Bononi (Edizioni Cacucci Editore – Bari) appena pubblicato e che si identifica con gli Atti del Congresso tenutosi a Thiene il 20/21 giugno 2024.
Il Congresso “La nuova Era di Latte e derivati” è stato organizzato dal Prof. F. Tateo e promosso dai F.lli Brazzale, ai quali si deve anche la pubblicazione degli Atti.
(*) Nota-testo di Fernando Gabriele Giorgio Tateo presentata al Convegno “I Dazi e altri vizi” del 6.05.25.
Facile cosa è dar colpa a terzi dei mali che affliggono la società e l’economia, ma se diamo uno sguardo introspettivo su ciò che noi mettiamo in atto per contrastare i mali stessi, rischiamo di scoprire ben poco di concreto nelle nostre azioni destinate a porre utili rimedi. Il ricorrere ad una declamatoria sui vizi della politica è uno dei più comuni sistemi adottati dal mondo di sempre per trovare discolpe. Nello stesso tempo il declamare sulle difficoltà di intervenire in modo efficiente per contrastare azioni a nostro chiaro danno messe in atto da “sistemi consolidati”, significa fare dichiarazione di discolpa della nostra inefficienza, e ciò non ha nessuna valenza costruttiva.
L’unico intervento da opporre, almeno in una società che si dice libera, è quello di intervenire e dimostrare, da parte di addetti ai lavori nei diversi comparti della vita operativa, che non è disponibile soltanto un popolo di succubi, ma che è disponibile anche un mondo capace di proporre contrapposizioni culturalmente guidate.
Chi vive di successi industriali nel mondo dell’alimentazione, come imprenditore o come professionista di ogni grado, non ha altro compito se non quello di opporre soluzioni corrette ed intelligenti proprio nei momenti difficili, come quelli che si delineano con l’applicazione dei dazi sugli alimenti trasformati. Occorre, invece che piangersi addosso, disporre di sufficiente capacità tecnica progettuale, di capacità di applicazione di tecnologie non improvvisate e sostenibili, di ingegnerie di progetto tecnologicamente adeguate ad una necessaria riduzione dei costi di produzione/trasformazione: il tutto con il concorso di studio attento e previsionale dei consumi dei trasformati nei Paesi definiti “protezionisti” in cui si tende ad esportare. La soluzione generale della problematica dei dazi, per i Paesi che hanno basato fino ad ora la stabilità, il benessere ed il trend positivo del pil sull’esportazione, sulla disattenta valutazione della capacità di vera propria autonomia e quindi sull’illusione di una stabilità infinita dei mercati, risiede ora soltanto nella presa di coscienza dello scempio che s’è fatto della cultura in questo Paese negli ultimi 30 anni. La mancata presa di coscienza di una gestione inconsulta attuata nella didattica, l’istituzione di semplificazioni nella formazione attraverso una didattica contratta al minimo anche lontano dall’indispensabile, ha condotto ad una semplificazione della cultura specialistica che non è più al passo con i tempi. Il danno culturale è stato realizzato proprio nelle tecnologie, con una accurata trascuratezza per il bisogno di incrementare lo sviluppo nell’innovazione, approssimata perché non sorretta da una cultura di base sufficiente a reggere il “gap” fra il livello sostenuto nei Paesi in cui non si è trascurata la programmazione dello sviluppo culturale e la tendenza adottata nel nostro approssimato stile della cultura tecnica e non tecnologica preferito dai gestori del nostro stile di vita.
Si assiste, giusto il tema di questo convegno, al bisogno immediato di “pregare” per eliminare barriere economicamente scomode senza prima attuare una politica di crescita della cultura che conduca all’incremento delle capacità di autonomia del nostro sviluppo tecnologico e che permetta una crescita dell’appetibilità verso la “nostra” produzione che abbia tutti i caratteri della stabilità e di una vera innovazione.
E’ veramente demotivante in termini di programmazione nazionale riscontrare che la tendenza si sia centrata sul protezionismo attuato attraverso le denominazioni d’origine rette da disciplinari e non da concreta attuazione di norme di qualità concretamente protezionistiche, che possano reggersi nel mondo alimentare con mezzi dettati da concreta cultura analitica. Si è quindi consolidato soltanto il vizio, non definibile diversamente, di nobilitare la nostra qualità attraverso un infantile vezzo d’uso di una dizione quale il “made in italy” che non ha una base scientifica concreta e che è basata sulla fortunata e casuale presenza dei “faraglioni di Capri” nel nostro mare piuttosto che nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico.
Sulla puerilità dei mezzi adottati per sostenere politiche viziate da sistemi non culturalmente radicati da impegno scolastico e didattico, l’unico che tradizionalmente non tradisce, ci sarebbe da disquisire impiegando tempi non certamente compatibili con quelli di un convegno nell’ambito del food.
Giova tuttavia ricordare che se oggi non occupiamo posizioni di particolare rispetto che meriteremmo qualora avessimo basato i fondamenti della tecnologia alimentare su una concreta didattica compatibile con le tradizioni di cui disponevamo, lo dobbiamo certamente a “vizi” acquisiti per trascuratezza per la “cosa pubblica” in termini di programmazione della cultura. L’insufficienza nella programmazione e nella didattica superiore, la voglia di semplificare i corsi di studio per emulazione di altri Paesi per indotta necessità di unificazione, il triennalismo degli studi mal “imparato” da altre realtà diverse dalla nostra, sono conseguenti ad un vizio instauratosi per danno prodotto dalla approssimazione e dalla sottovalutazione delle necessità primarie, fra cui non compare certo quello di superare il “disturbo” dei dazi. Il superamento di difficoltà relazionali in campo internazionale, la demotivazione per il trasferimento dei “cervelli” all’estero e l’imposizione delle nostre tecnologie (altro che di dazi!) è possibile soltanto attuando una politica di formazione culturale che non lasci spazio a semplificazioni nella didattica: ci si riferisce a semplificazioni del tipo di quelle adottate a seguito dei decreti sul triennalismo di formazione e su tutti gli altri sistemi altamente semplificati di formazione che stanno devastando la cultura tecnico – scientifica del nostro Paese.
Sarebbe opportuno, più che altro, rivedere il criterio di giudizio sulla gravità dei “danni di ogni genere” e considerare in primo luogo quelli che oggi si perpetrano a danno delle economie indirette: prima d’ogni altro, il danno provocato dalla gestione improvvisata della didattica e dell’organizzazione degli studi, fattori che condizionano l’economia della cultura.